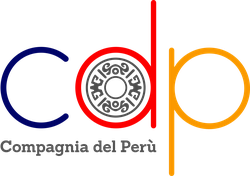Conoscete la canzone “To build a home” ?
Prendete il telefono, isolatevi dal mondo per quattro minuti e mentre la ascoltate continuate a leggere…
Quest’estate in Perù, a Trujillo, al Caef e più nello specifico seduta su una sedia nel comedor, una ragazza di 14 anni di nome A. è riuscita a costruire una casa per me e per lei. Una casa costruita sulla pietra con tavoli e sedie consumate dalla polvere, pavimenti e mura colorate:
“this is the place where I don’t feel alone,
this is the place where I feel at home”.
Lei è riuscita in un’impresa che riconosco a pochissimi altri nella mia vita: si è fatta spazio tra tanti, si è conquistata un posto nella mia memoria, non tra i miei ricordi badate bene, e si è silenziosamente presa un pezzo di me sentendosi in dovere di costruire una casa che potessimo chiamare “nostra”. Come?
Rifiutandosi di truccarsi solo per gioco, di improvvisare balli di gruppo nel patio assolato, di ridere di gusto fino alle lacrime ma, soprattutto, rifiutandosi di parlare tanto o semplicemente a vanvera.
Lo ha fatto, insomma, nel migliore dei modi: con lo sguardo, uno di quelli che non mi era mai capitato di incrociare. Uno sguardo che dice tutto sul futuro e nulla sul passato perché l’importante non è quello che uno ha subito nella vita ma come decide volontariamente e consapevolmente di usarlo per costruirsi un futuro, come decide semplicemente e difficilmente di prendere una decisione a riguardo.
E così lei ha fatto, è partita dalle fondamenta: conoscermi utilizzando una lingua estranea ad entrambe. I pomeriggi passati insieme a studiare e a conoscerci per la prima volta sono stati le fondamenta di tutto il nostro rapporto, ancora non lo sapevo ma lei aveva già iniziato a costruire. Ho un ricordo vivido nella mia mente, mi sembra ancora di vederla seduta al tavolo più vicino ai piccoli scalini del comedor intenta a cullare il suo bambino e, contemporaneamente, a scrivere sul suo quaderno a quadrettoni.
Mi sono avvicinata perché avevo la responsabilità di aiutarla a studiare e ho finito per sedermi ogni giorni lì con lei perché avevo il bisogno di aiutarla a studiare. Finiti i compiti scolastici arrivava sempre la solita timorosa e speranzosa frase detta sottovoce “Ahora, el ingleis por favor…”.
E così ho cercato di passarle tutta la mia limitatissima conoscenza di una lingua che risultava essere straniera tanto a lei quanto a me attraverso tabelle con colori, numeri, frasi di rito per occasioni varie e qualsiasi altra cosa mi passasse per la testa. Rido ancora oggi a pensare alle nostre conversazioni fatte in tre lingue….ridereste anche voi!
A., subito dopo, ha iniziato a tirar su muri e a costruire pavimenti per quella che doveva essere casa nostra e questo è stato possibile grazie ad I.: sei mesi di tenerezza e pacatezza tutti concentrati in un batuffolo d’uomo. Mi ha fatto conoscere suo figlio permettendomi di cullarlo mentre cercava di mangiare, di tranquillizzarlo durante la messa improvvisando strani giochini con la mia grande sciarpa gialla ed, infine, permettendomi di coccolarlo e prenderlo in braccio durante la faticosa prima cena al campamento dove i sensi di colpa e le responsabilità stavano davvero avendo la meglio su di lei. Il rapporto che ho stretto con I. è stato il collante di quello stretto con A perché un figlio, nonostante tutto ciò che è accaduto e nonostante tutti, rimane il miglior riflesso di te stessa.
Il tetto e il cancello sono stati costruiti in un secondo momento, quando era chiaro ad entrambe che quello che avevamo era qualcosa di speciale. Allora capitava che, durante le chiassose sessioni di attività pomeridiane, mi guardassi intorno e incrociassi il suo sguardo ed eccola lì…l’intesa! Era fatta di piccoli gesti come i pranzi insieme, i telefilm spagnoli che guardavamo sedute vicine sul divano, i sorrisi a distanza quando gli impegni giornalieri ci separavano e gli abbracci della buonanotte che ci scambiavamo dopo aver trasportato faticosamente (almeno per me) il passeggino giù per gli scalini del comedor.
Il tetto e il cancello all’ingresso sono stati ideati con uno scopo ben preciso, quello di non far entrare chiunque in quella che ormai era a tutti gli effetti casa nostra. In realtà, la porta è poi rimasta sempre aperta e me ne sono resa conto perché ho iniziato a vedere sul suo volto una smorfia che non può in assoluto definirsi un sorriso nell’accezione classica del termine ma lo era, era il sorriso di A. che riconoscerei tra mille.
E adesso penserete che la casa sia finita, giusto? Sbagliato! Manca la componente più importante di tutte: il tempo cioè l’arredamento. Beh, in questo caso, la promessa è stata quella di rivederci, di costruire altri frammenti di memoria insieme, di tornare in Perù, a Trujillo, al Caef e a quel tavolo del comedor dove è iniziato tutto, dove una ragazza di 14 anni di nome A. è riuscita in un’impresa impossibile: dare una casa a me che l’avevo persa facendomi addormentare ogni notte al sicuro lasciando finalmente la porta aperta.
Per A., per I., per tutti noi.
Giorgia Cretoni