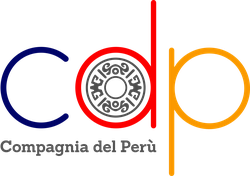Cronache sparse dal Ciclo della Campiña
- “Quanto deve essere lunga?” - chiesi a Titti mentre sedevo sul divano all’entrata della casa.
- “Mah…più o meno due cartelle” - rispose, ed io per annuire feci della mia testa un ciondolo, perché in quel preciso momento non sarebbe potuto essere altrimenti. In maniera del tutto inconsueta una sensazione di profonda stanchezza si confondeva alla sincera soddisfazione per quanto avevo vissuto finora.
Ripensandoci ora, senza nemmeno saperlo in quel momento stavo raccogliendo i frutti di un lavoro corale, sentendone il sapore scorrere in ogni fibra del corpo e in ogni sfumatura dell’anima. È questo dunque il primo frammento d’esperienza che vorrei si riflettesse: vivere il campo significa sperimentare l’unione, significa indagarne gli angoli remoti e inaspettati per poi godere d’ogni nuova prospettiva, conquistata col sudore proprio e delle compagne e compagni con cui si condivide la lotta. Parlo di lotta e non per mero artificio retorico, ma perché il campo di volontariato è anche campo di battaglia, un terreno su cui ci si scontra con le difficoltà quotidiane di un emisfero in cui ad essere diverso non è soltanto il cielo ma anche e soprattutto il modo di condurre la propria vita (e qui ci aggiungerei anche il modo di condurre la propria auto! Fidatevi, sui taxi “ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi”).
In Perù, se davvero se ne vuole cogliere la cifra umana, bisogna entrare e uscire dai luoghi in punta di piedi, perché il malinteso culturale è all’ordine del giorno. Come nel ricco distretto centrale del Cercado de Lima, che sembra così familiare ai nostri occhi occidentali, con il McDonald a lato della Cattedrale e il cambiavalute a poca distanza dalla piazza. Eppure, è proprio lì che, a seconda della sorte ricevuta alla nascita, un bambino può ritrovarsi a giocare spensierato o a vendere gomme da masticare al turista di turno in cerca di foto.
Oppure come a Tablada de Lurin (Cono Sur, periferia di Lima) dove, anche se si respira polvere e miseria, il sorriso sul volto di Daniela e Maruja mentre s’accingevano al racconto delle loro esperienze, ci ha permesso di capire come povertà e ignoranza generano violenza e che queste tre, prima di essere variabili sociali che influenzano lo sviluppo di un territorio, sono piaghe mostruose che divorano gli esseri dall’interno, cibandosi della loro umanità.
Seduti nel porticato del suo piccolo eden, Daniela ci ha raccontato storie di battaglie combattute negli anni in difesa di creature scappate, minacciate, violentate, di giovani partorienti e anziane abbandonate. Con i piedi sporchi di fango siamo entrati nella Casa della Cultura, una biblioteca sociale a disposizione dei giovani abitanti della Tablada, perché “solo attraverso la cultura i nostri figli saranno davvero liberi”. E dunque oltre al sostegno extrascolastico, Maruja e Daniela si occupano di riempire lo stomaco e la mente dei ragazzi di periferia, perché entrambe sanno fin troppo bene che solo una bocca sfamata ed istruita, crescendo, avrà in dote una voce per parlare con parole di pace ed onestà. Lasciando il distretto di Lurìn, testimone di quanto avevo visto, compresi che il breviario cavalleresco di cui avevo bisogno per iniziare la mia avventura si poteva riassumere nel sorriso di quelle due donne, così piccole nella loro forma fisica, così immense nel loro spirito guerriero.
Non è un caso se ho ritrovato poi lo stesso sorriso sul volto di Judith, madre dolce e giusta per ogni creatura che varca la porta del Caef. Quando fui io a varcare quella porta, potendo finalmente fissare meglio la sua figura, ebbi subito l’impressione d’avere di fronte una donna senza paura, senza timore di affrontare la propria missione, una guerriera coi piedi ben piantati per terra e la testa circondata da nuvole di ispirazione. Il suo “compromiso” (parola bellissima con cui in spagnolo si indica l’impegno profuso per una causa) traspare materialmente dalla voce ma soprattutto dal suo sguardo – a volte gioioso, altre volte misterioso, mai vuoto – e dal primo all’ultimo ospite della casa può testimoniare come, persino il più indisciplinato dei bambini diventa naturalmente mansueto alla sua presenza. Perché le piccole creature che riempiono di urla giocose e lunghi silenzi gli spazi del Caef, nonostante il carico di traumi di cui già si fanno carico o forse proprio in virtù di quei drammi, riconoscono in Judith la campionessa di un’infanzia sottratta e perciò da riscattare. Ecco un’altra chiave di lettura per questa esperienza: il riscatto.
Io, che volevo lasciare i luoghi sicuri verso mete sconosciute con la voglia di mettere alla prova il mio valore, avevo finalmente trovato uno scopo verso cui orientare le mie energie. Riscattando un briciolo di felicità e d’immaginazione nella vita di creature che sono condannate troppo presto ad abbandonare ogni sogno di crescita e realizzazione, ho riscattato parti di me che non conoscevo o che avevo sepolto da tempo.
Forse queste parole potranno risultare dure o altezzose per chi non riesce a concepire ciò di cui scrivo, potrebbero stimolare particolarmente l’immaginazione per chi invece ha bisogno come me di sfidarsi continuamente, come potrebbero benissimo risultare parole vuote, prive di senso. Allora mi sforzerò, almeno in chiusura, di essere più chiaro. Se chi legge avrà la curiosità e qualche minuto di tempo libero, aprendo Google Maps alle seguenti coordinate (8°10'07.6"S | 79°01'25.5"W) troverà la Canchita, un campetto in cemento circondato da case fatiscenti e terreni incoltivabili. Proprio lì portavamo a giocare los niños de Torres, bambini a cui il Caef lungo l’arco dell’intero anno, offre occasioni di svago ma soprattutto la possibilità di studiare oltre le normali ore scolastiche. Si tratta di luoghi dove i bambini giocano sull’oceano senza sapere se il Perù affacci sul Pacifico o l’Atlantico, e spesso senza nemmeno sapere bene dove sia il Perù sulla mappa, quando se ne trova una. Luoghi dove, oltre ai bambini, il Caef si occupa di istruire e formare anche le famiglie, perché la violenza si nasconde sempre troppo facilmente fra le mura di fango e lamiere di villaggi come Torres de San Borjas, e va combattuta anche quando non la si vede.
Ero per l’appunto in Canchita assieme alle mie compagne e compagni d’arme, circondati da niños che salvo qualche raro caso, giravano quasi sempre scalzi e ricoperti di abiti consumati. Quel pomeriggio, letteralmente dal nulla, ci apparve una bambina vestita con un grazioso abito bianco da damigella. Il colpo d’occhio era impressionante: sedevamo tutti a terra per giocare al gato y el ratòn e quel punto bianco lo si sarebbe potuto notare da almeno cento metri in lontananza. Ancora adesso, dalla mia scrivania alle porte di Roma a più di 10.000 km di distanza dall’Oceano Pacifico, riesco a notare quel puntino bianco. Fatto sta che nessuno di quei bambini parve sorpreso o colpito da quella presenza dall’aspetto così elegante. Solo dopo capii che per quei niños, così impegnati a ridere e scherzare fra loro e con noi, poco contava se in Canchita ci si andava vestiti di stracci o in abito da sera. L’importante era giocare!
Ora che ci ripenso, rivedo nitidamente la stessa scena di quel cerchio di anime selvagge ed innocenti, splendidamente sorridenti e però stavolta vestite di tutto punto: Manuelito col Tuxedo, Milagros in Tailleur, Valentina ricoperta di Chiffon, Julio e Daniel in Frac…. perché quando si andava a giocare per loro era sempre e comunque serata di gala e noi, che eravamo i maestri di cerimonie, dovevamo celebrare al meglio la loro festa. A terra in cerchio o correndo, giocando con una palla, una corda, ballando, prendendoli in braccio, sulle spalle, abbracciandoli, facendoli volare in aria, portandoli in giro per mano, così riscattavamo giorno dopo giorno qualche sorriso sui loro volti. E questa è tutta la ricchezza del mondo per cui vale la pena lottare.