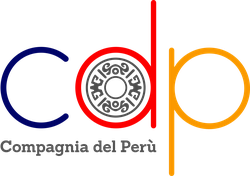La mia casa a testa in giù.
Non è facile descrivere a parole quello che si vive in Perù, mettere per iscritto un caleidoscopio di emozioni, neanche quando si torna per la quarta volta.
Sono partita dopo sei anni di assenza, cinque estati di lontananza nelle quali spesso mi sono dimenticata del CAEF, dei bambini e delle loro storie, dell’impegno e del coraggio di Judith e degli educatori; ma il Perù mi ha chiamato di nuovo, quando il mio “Io”, troppo grande e pesante, stava soffocando tutto lo spazio dell’ “Altro”. E allora con molta paura, ma incredibile fiducia, ho fatto il biglietto, ho volato tredici ore e sono atterrata là dove nove anni fa ho capito che una casa non è di muri, ma di cuori.
Quest’anno il Perù non si è mostrato violentemente come le prime volte, ma ha fatto capolino piano piano, in silenzio, e spesso si è manifestato attraverso gli occhi degli altri, laddove i miei non vedevano; occhi altrui che mi hanno fatto conoscere persone che non ho incontrato, emozionare per situazioni che non ho vissuto, contemplare sguardi che non ho visto.
Mi sono commossa in silenzio a Lima quando, in mezzo al grigiore della periferia del Cono Sur, Maruja ci ha mostrato un’azzurrissima piscina fisioterapica per i bimbi disabili della zona; tra tanta sabbia e sporcizia un’acqua di speranza segno del coraggio di una donna che da 25 anni ha abbandonato la sua vita e la sua casa, una donna che non si limita a bagnare di tanto in tanto la mano nella povertà, ma che vi s’immerge tutta sforzandosi di brillare nel torbido della corruzione e della criminalità che la circondano. Un coraggio di cui non sono capace e che mi fa vergognare.
Poi siamo arrivati al CAEF e mi sono commossa di nuovo: mi hanno accolta quelle mura colorate, che per me sono Casa, tra le quali rimbombano risate, frusciano abbracci e si raccontano ferite, un posto dove odi costantemente il lavorio febbrile dell’amore, un’officina del cuore, dell’autostima, della riappropriazione del sé, del valore altrui. Un luogo dove non sono altro che me stessa, e il mio mese si permea della consapevolezza straordinaria di non poter essere altrove, l’indicibile sensazione che questa famiglia a testa in giù mi regala.
Ed ecco Torres, una manciata di mattoni buttati su una duna al limitare dell’oceano: ancora una volta è casa, pur così diversa da dove vivo, ma dove otto anni fa ho seminato un pezzo del mio cuore, un luogo a cui appartengo e che amo. Una bellezza fatta di terra e odori forti, di piedi scalzi e abbracci, di giochi e canti urlati forte dai volontari e imitati dai bimbi timidamente divertiti.
Ricordo l’eccitata attesa di tornare, l’impazienza di Benedetta, incollata al finestrino e incapace di stare ferma, i sorrisi emozionati scambiati tra noi italiani sul pullman che ci portava là, la commozione dell’arrivo al vedere i miei bimbi lasciati sei anni fa e ora cresciuti; un grappolo di sensazioni che il cuore umano, da solo, non sa costruire, ma che, pur con le mie fatiche e i miei dubbi, mi parla di una scintilla che viene dall’Alto, di un “prenditene cura” che sa di Missione.
Mi emoziono a pensare al pranzo offertoci da una mamma, orgogliosa per ciò che fa sua figlia e grata del lavoro svolto da noi con passione e dedizione nella sua comunità. Gli occhi di noi volontari brillavano mentre ci facevamo passare i piatti di arroz e aji de gallina preparati con cura, mentre ringraziavamo chi ci aveva invitati e preparato il pranzo, mentre ammiravamo il paesaggio del Serro Blanco dalla porta aperta; usciti da quella casa il nostro sguardo verso Torres era ancora diverso e riempito di un senso di appartenenza che sarà per sempre parte di noi e che in qualche modo, spero, indirizzerà sempre le nostre scelte. Torres, il CAEF, bussole di verità e di senso.
Nel bagaglio di ritorno mi porto un nome e un ricordo: J., ex bambino del CAEF, ora quasi uomo, in carcere per un piccolo reato. Al mio primo Campamento era nella mia squadra: monello e superattivo, al limite dell’ingestibilità, mi faceva letteralmente andare fuori di testa; ma alla despedida si era seduto in silenzio in braccio a me, nonostante non fosse più piccolo, aggrappandosi alle mie mani.
In valigia metto ancora gli occhi di A., 14 anni, lucidi di lacrime ferme e silenziose al momento della nostra partenza. Lacrime che parlano dell’amore provato e donato durante il mese, lacrime che significano per me impegno e presenza, dono e affidamento; e quando il mio “Io” starà per soffocare l’ “Altro” vorrei che mi ricordassi quegli occhi, il nome di A. e quello di J.
Non posso fare altro che pensare alla conclusione della lettera motivazionale pre-partenza di quest’anno: “Voglio tornare a commuovermi per qualcosa al di fuori di me” avevo scritto.
Il Perù fa questo: ti svuota da quello che credi di essere svelando un’identità genuina, ricalibrando i valori, stabilendo un’autenticità che rende liberi. Il difficile ora è innaffiare poco a poco il quotidiano con questa consapevolezza, rimanere fermi in un mondo che porta dall’altra parte, mostrare attraverso i nostri occhi il riflesso di quella Bellezza che abbiamo avuto il privilegio di conoscere.